La Colombia ha una nuova bussola per prendere decisioni in merito al cambiamento climatico: ci permetterà di sapere dove pioverà meno o dove farà più caldo.

"Oggi forniamo alla Colombia uno strumento di previsione centenaria per una pianificazione basata su prove concrete". Con questa dichiarazione, l'Istituto di Idrologia, Meteorologia e Studi Ambientali (IDEAM) ha presentato qualche giorno fa gli Scenari dipartimentali sui cambiamenti climatici, una bussola in grado di orientare le decisioni chiave nell'affrontare le sfide del cambiamento climatico nelle diverse regioni del Paese.
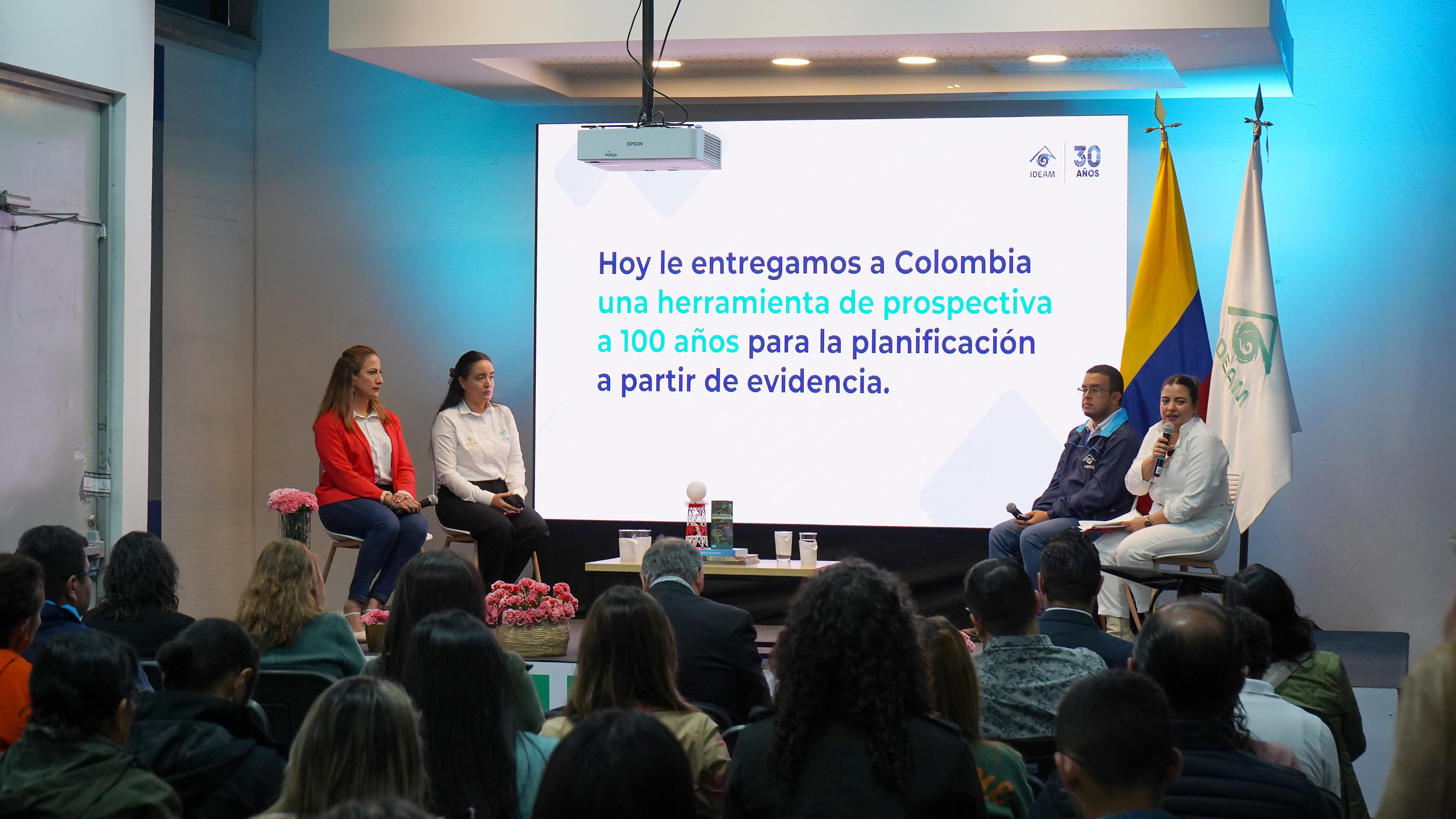
Presentazione degli scenari dipartimentali sui cambiamenti climatici da parte di IDEAM. Foto: IDEAM
Questi scenari erano già noti nel loro formato nazionale, ovvero per l'intero territorio colombiano. Ma ora, con l'aggiornamento presentato dall'ente responsabile degli studi meteorologici e climatici del Paese , è possibile conoscere nei minimi dettagli come potrebbe comportarsi il clima durante questo secolo, specificamente in ogni dipartimento del Paese.
È fondamentale sottolineare che questi strumenti non sono previsioni, ma piuttosto un contributo al processo decisionale fornito nell'ambito della Quarta Comunicazione Nazionale sui Cambiamenti Climatici, ovvero relazioni periodiche che i Paesi sottopongono alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC).
In questo senso, questi modelli offrono una serie di scenari che ci permettono di anticipare possibili futuri in base a diverse traiettorie di sviluppo globale. Dipendono in larga misura dalle decisioni che il pianeta prenderà per affrontare il cambiamento climatico, ma servono da guida per ciò che ci attende se il pianeta deciderà di continuare a bruciare combustibili fossili domani o di decarbonizzare rapidamente.
Come funzionano? Gli scenari climatici sono simulazioni scientificamente elaborate che aiutano a immaginare come potrebbe comportarsi il clima in futuro in diverse condizioni globali e sociali. Questi scenari si basano sui Percorsi Socioeconomici Condivisi (SSP), ovvero insiemi di proiezioni sviluppate dal Gruppo Intergovernativo di esperti sui Cambiamenti Climatici (IPCC) e che raggruppano futuri alternativi a seconda di come il mondo evolve in aspetti chiave come la cooperazione internazionale, la crescita economica, la disuguaglianza, l'uso di energia pulita e i modelli di consumo.
La Quarta Comunicazione Nazionale utilizza quattro di queste traiettorie: SSP1, SSP2, SSP3 e SSP5 (nelle loro versioni più aggiornate). Ognuno di questi scenari rappresenta un diverso livello di emissioni di gas serra e, quindi, di conseguenze climatiche per il pianeta. SSP1, ad esempio, è considerato uno scenario ottimistico: si tratta essenzialmente di un partenariato con una forte cooperazione globale, in cui la transizione energetica viene accelerata e le emissioni vengono drasticamente ridotte, con l'aspettativa di limitare il riscaldamento globale a meno di 2°C. E sebbene sia l'unico in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, questo non è lo scenario globale attuale in cui ci troviamo.
SSP2, d'altra parte, propone un futuro intermedio, con uno sviluppo parzialmente sostenibile, progressi moderati nella riduzione delle emissioni e una governance climatica frammentata. SSP3 descrive un mondo più conflittuale, con tensioni geopolitiche, bassi livelli di cooperazione ed emissioni in costante aumento. SSP5 è il più critico: una società ipertecnologica che rimane dipendente dai combustibili fossili, senza controlli sulle emissioni, il che porterebbe a un aumento molto più rapido della temperatura globale.
In questo senso, gli scenari climatici sono una bussola: una guida che mostra, in base a ciò che accade nel mondo, la probabile direzione in cui si muoverà il Paese, in modo che i leader e i decisori abbiano la capacità di pianificare le strategie necessarie per affrontare, ad esempio, aumenti di temperatura superiori a 4°C o una diminuzione del 30% delle precipitazioni.
Gli scenari forniscono dati su molteplici variabili climatiche, come temperatura, precipitazioni, umidità e frequenza di eventi estremi, proiettati su diversi orizzonti temporali . Ciò consente di analizzare i potenziali impatti sui sistemi naturali e umani, come colture, approvvigionamento idrico, infrastrutture, salute pubblica ed ecosistemi.
"Si tratta di uno zoom territoriale che migliora la precisione dell'analisi", ha affermato la direttrice di IDEAM, Ghisliane Echeverry, durante un'intervista con EL TIEMPO. "Con questi modelli, possiamo visualizzare possibili scenari anno per anno e trimestre per trimestre, non come una previsione una tantum, ma come un potente strumento di pianificazione territoriale".

Ghisliane Echeverry Prieto, direttrice di Ideam. Foto: Idea
Uno degli esempi più allarmanti mostrati dagli scenari è a La Guajira, dove IDEAM prevede una riduzione delle precipitazioni dal 10% al 20% , accompagnata da un aumento della temperatura compreso tra 1,5°C e 2°C, a seconda dello scenario. "Questo è piuttosto grave e preoccupante", ha avvertito Echeverry. "È già un dipartimento molto secco e un'ulteriore diminuzione delle precipitazioni potrebbe avere un impatto drammatico sulla sicurezza idrica, sugli ecosistemi e sulla salute".
Ma l'impatto non sarà uniforme in tutto il Paese. "Ci sono dipartimenti in cui le precipitazioni potrebbero aumentare. Ecco perché è così importante che i decisori abbiano accesso a queste informazioni. Perché non tutti saranno colpiti allo stesso modo. E le politiche pubbliche non possono basarsi sulle medie nazionali", afferma il funzionario.
La direttrice ha anche messo in discussione le decisioni storiche di pianificazione idrica, ora vulnerabili a questi nuovi scenari. "Tutti i bacini idrici sono concentrati nella regione andina, con gli stessi andamenti delle precipitazioni. Ma se quell'area subisce un deficit idrico, l'intero sistema collassa. Nel frattempo, regioni come il Pacifico, che presentano abbondanti precipitazioni, non dispongono delle infrastrutture per immagazzinare l'acqua", avverte.
Secondo Echeverry, il valore più grande di questi scenari risiede nel loro potenziale di anticipazione. "Non si tratta di allarmismo. Si tratta di prendere decisioni strategiche. Dove posiziono un bacino idrico? Dove non ha senso piantare una certa coltura? Come posso adattare le infrastrutture a scenari di caldo estremo o forti piogge? Tutto questo può essere pianificato meglio con queste informazioni", aggiunge.
"L'acqua del futuro non è l'acqua di oggi" Per Diego Restrepo Zambrano, esperto di scienze idriche e adattamento climatico, uno dei punti chiave degli scenari aggiornati è che ora saremo in grado di prendere decisioni migliori in materia di acqua, per evitare problemi come quello sperimentato a Bogotà tra il 2024 e il 2025 a causa del razionamento.

I bacini idrici di Bogotà sono stati colpiti dalle scarse precipitazioni nel 2024. Foto: El Tiempo
"Questo è fondamentale per i comuni, perché saranno in grado di gestire i propri territori in modo più appropriato, tenendo conto delle problematiche di rischio, ma anche di quelle relative all'approvvigionamento idrico", afferma Restrepo. Informazioni climatiche localizzate, sostiene, consentiranno loro di rispondere a domande cruciali come "dove pioverà di più, dove pioverà di meno, dove le temperature aumenteranno, dove gli ecosistemi saranno a rischio a causa del clima".
Tuttavia, avverte che è ancora necessaria una profonda trasformazione istituzionale affinché queste informazioni abbiano un impatto concreto sulle politiche pubbliche: "È necessaria una nuova politica che includa il cambiamento climatico negli strumenti di pianificazione... Oggi abbiamo molti strumenti di pianificazione, ma nessuno di essi include il cambiamento climatico, nessuno di essi include i rischi associati alla diminuzione o all'aumento delle precipitazioni".
Per illustrare questa urgenza, Restrepo sottolinea l'importanza dei bacini idrografici e delle zone umide come strategie di adattamento naturale. "Diventeranno ancora più importanti nei luoghi in cui ci saranno più precipitazioni e, di conseguenza, un maggiore rischio di inondazioni. Questi ecosistemi possono contribuire a ridurre il rischio di inondazioni in futuro, ed è proprio questo l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici", sottolinea. Ma affinché ciò accada, chiarisce, "le politiche pubbliche devono concentrarsi sugli sforzi che IDEAM sta compiendo per generare questi scenari, in modo che possano essere inclusi negli strumenti di pianificazione".
Che cosa manca Per Benjamín Quesada, climatologo e direttore del corso di laurea in Scienze del sistema terrestre presso l'Universidad del Rosario, sebbene questi nuovi scenari climatici presentino notevoli miglioramenti rispetto alle edizioni precedenti (la terza comunicazione nazionale sui cambiamenti climatici è stata presentata nel 2015 e i successivi contributi sono stati forniti negli anni successivi) , ci sono ancora molte informazioni in sospeso che sono necessarie affinché il Paese si prepari al meglio.
"Questa edizione ha compiuto un maggiore sforzo in termini di trasparenza, in particolare a livello metodologico e con la possibilità di scaricare i dati di base, e a livello di diffusione, fornendo ai decisori input geograficamente disaggregati per diverse variabili climatiche di interesse", spiega Quesada. Oltre al suo valore tecnico, il geoportale IDEAM consente anche il download aperto dei dati di proiezione e la simulazione di traiettorie di sviluppo con emissioni più elevate o più basse. Questo, afferma Quesada, "può orientare le politiche di adattamento rispetto a quelle di mitigazione e aiutare a stabilire le priorità degli investimenti in base al contesto locale".
Tuttavia, l'esperto chiarisce che il modello ha ancora "ampi margini di miglioramento per raggiungere realmente capacità ottimali di pianificazione territoriale e adattamento". In primo luogo, critica "il limitato coinvolgimento del mondo accademico e della revisione paritaria" nella costruzione tecnica degli scenari. A ciò si aggiungono "l'assenza di proiezioni oceaniche, la mancanza di comunicazione riguardo alla potenziale incertezza o robustezza tra i modelli in alcuni dipartimenti e l'assenza di spiegazioni fisiche per i cambiamenti previsti rispetto alla letteratura esistente e/o alle precedenti edizioni di IDEAM". Per Quesada, colmare queste lacune richiederà una maggiore collaborazione scientifica e istituzionale: "Tutto ciò richiederà una ricerca più collaborativa".
Secondo il climatologo, in definitiva, la chiave dei dati è utilizzarli per progettare soluzioni, ma in collaborazione con le comunità più vulnerabili, che in ultima analisi sono le più colpite dal clima. "Con le comunità locali, in particolare quelle vulnerabili, comprese le popolazioni indigene o sfollate, dobbiamo progettare congiuntamente misure che rispondano ai loro bisogni sociali e culturali, come l'agroforestazione per proteggere le foreste tropicali secche e dare priorità alle risorse idriche per usi vitali, piuttosto che industriali", conclude.
Giornalista ambientale e sanitario
eltiempo





